Dissonanze per un delitto. Ennio Morricone nel cinema thriller italiano
![]() Marco Ferretti
Marco Ferretti
Dissonanze per un delitto. Ennio Morricone nel cinema thriller italiano (2023)
Shatter Edizioni
pp. 448 - € 26,00
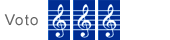
DISSONANZA: Unione di suoni che non s’accordano e producono un effetto sgradevole all’udito (e a volte può riuscire vivacemente suggestivo). Capacità di certi intervalli o accordi di produrre un’impressione di sospensione, di instabilità, di provvisorietà che attende una risoluzione, dovuta al fatto che i suoni che li compongono restano nettamente distinti (ed è il contrario di consonanza) (Dizionario Battaglia della lingua italiana)
“Una musica come quella […], tutta dissonanze e stridori, non s’era mai ascoltata” (EUGENIO MONTALE, Farfalla di Dinard)
Stregoneria dei titoli. Un titolo pareggia un intero libro, un intero film. Evoca, incuriosisce, affascina, invoglia. E’ sempre una promessa, talvolta mantenuta talaltra no. Nel caso di Marco Ferretti, il debito che ogni promessa implica è saldato con discreti interessi. E poi, oltre le pagine rimane, isolata nella sua indeterminata bellezza, quell’onomastica, stato nascente che proietta in un Altrove vago, quintessenza di fantasie. "Dissonanze per un delitto" potrebbe essere il titolo di un film. O anche – e meglio - di una composizione musicale – applicata o “assoluta” - incentrata sulla disarmonia dei suoni e delle situazioni. Il sottotitolo "Ennio Morricone nel cinema thriller italiano" ci riconduce allo specifico di un musicista e di un tipo di cinema che contrassegnarono la stagione dalla metà dei Sessanta a tutto il decennio seguente.
Ecco un libro due volte coraggioso. Perché tratta un argomento – la musica del cinema - che, per quanto sdoganato rispetto a qualche decennio fa, resta di nicchia, appannaggio di un pubblico ben esiguo rispetto ai cultori della classica da un lato e delle varie forme della popular music dall’altro. Occuparsi di Ennio Morricone, l’unico compositore cinematografico davvero “popolare” e noto, anche solo per sentito dire, può attenuare le distanze. Ma qui interviene il secondo e più netto, quasi temerario atto di coraggio: soffermarsi su un certo Morricone meno conosciuto (una “distorsione culturale” nota giustamente Ferretti) e meno fruibile, autore di combinazioni sonore lontane dalle abitudini dell’ascoltatore medio, che nella musica cerca sempre la cantabilità, alta o trivial poco importa. Il Morricone “popolare” (come potevano esserlo Rossini o Verdi nella loro epoca) è il “melodista straordinario” (1) che utilizza il linguaggio tonale al servizio di armonie inserite entro una sintassi nota, nella quale chi ascolta si può riconoscere pur percependola ingegnosa e fuori target. Poi, c’è l’«altro» Morricone: quello della musica “assoluta”, non scritta per il cinema e pertanto più libera, dove puoi permetterti di essere sperimentale, avanzato; e di inserire le formule della “nuova musica” novecentesca; soprattutto, di rifiutare la melodia e la tonalità, o almeno ridurle a schegge episodiche. Tale Morricone alternativo trascolora al bisogno, attraverso accurati dosaggi e qualche addomesticamento, nell’ambito applicato del cinema, là dove se lo può consentire: pellicole ostiche e/o di piccolo budget, richieste specifiche del regista come Pasolini per Teorema (1968), garanzie di libertà compositiva. Ecco allora Un uomo a metà (Vittorio De Seta, 1966) confluito poi in musica per balletto (“Requiem per un destino”, 1966), Un tranquillo posto di campagna (Elio Petri, 1968), rielaborazione peraltro di “Musica per undici violini” di dieci anni prima; Todo modo (Elio Petri, 1976); ed altri sino, a fine carriera, il tarantiniano The Hateful Eight. Il Maestro romano si sentì autorizzato a scrivere musica “difficile” anche per soggetti pervasi da climi allucinati e pieni di ammazzamenti sanguinosi e psicopatie (una equazione, quella tra negatività e atonalismo e procedimenti vari della musica contemporanea, contestata da Sergio Miceli) (2). In concreto, il giallo italiano, istituzionalizzato da Argento e divenuto un genere a sé, vivissimo in quei Settanta che furono il decennio più ardito e creativo del cinema nel paese del sì. L’impiego prevalente dell’atematismo, della dissonanza, del frammento, della modularità conferivano a quelle partiture una dimensione allotria, una metafisica del Male che l’usuale suspense ed action music – assai più naturalistiche ed epidermiche - non possedevano. Linguaggio difficilmente riproponibile da altri (con l’eccezione Bruno Nicolai) e per ciò a ridotto rischio di banalizzazioni (al contrario, nel western troppi vollero essere “morriconiani” e rimasero epigoni, salvo ancora una volta Nicolai).
Oggetto dell’indagine di Marco Ferretti (classe 1984, specializzato in studi storico-politico-diplomatici, giornalista e, pour cause, esperto cultore di musica applicata e cinema di genere, fondatore dell’etichetta “Musica per immagini”) è appunto il Morricone “secondo”, del cinema thriller nella fattispecie. Peraltro, la categoria viene intesa in senso esteso. Non solo il “giallo”, tipologia narrativa già di suo trasversale; invece tutto un cinema distonico, la distonia come fatto esistenziale e interpretata tramite soluzioni dissonanti e talvolta anche consonanti per quanto all’insegna di un melodismo bizzarro, arcano, morboso. Dunque, oltre al thriller canonico, il noir, il poliziottesco, il mafiamovie, il gotico; ed anche certo cinema di contestazione e nevrosi dei tardi Sessanta, il disagio socio-economico, le perversioni assortite generatrici di mostri, persino la commedia agra: tutto un cinema abitante il pianeta proibito dei “mondi neri” (felice sintagma coniato da Alessandro Tordini) al quale il compositore fornì di volta in volta gli atout necessari, l’adrenalina giusta, il sound magnetico che ci consentono di parlare di un cinema targato Ennio Morricone che sarebbe stato solo grande e invece, plasmato dai suoni dell’artifex, fu enorme e rivive oggi nell’ascolto di una musica che è sguardo e rêverie.
L’autore ha selezionato 56 titoli afferenti al “genere” inteso quale categoria obliqua: rimaneggiabile a piacimento, inseribile all’interno di pellicole distanti – per ambizioni autoriali, complessità ideologico-tematica e soluzioni stilistiche - da quelle del cinema cosiddetto bis (il quale poi non esclude affatto una propria ben definita autorialità in più casi). E allora, accanto ad Argento e seguaci, ecco il gotico-horror Amanti d’oltretomba (Mario Caiano, 1965) con il quale si apre la silloge, l’iconoclasta I pugni in tasca (Marco Bellocchio, 1965), la “trilogia della nevrosi” di Elio Petri (1970-1973), Vergogna schifosi (Mauro Severino, 1969), Metti, una sera a cena (Giuseppe Patroni Griffi, 1969), La califfa (Alberto Bevilacqua, 1971), Milano odia: la polizia non può sparare (Umberto Lenzi, 1974), La donna della domenica (Luigi Comencini, 1975), L’ultimo treno della notte (Aldo Lado, 1975); sino a concludere con Il giocattolo (Giuliano Montaldo, 1979). Tutte le sfumature del nero, verrebbe da dire. In rapporto alla più che pentalustre attività di Morricone nel cinema, l’arco cronologico considerato appare assai ristretto, un quindicennio appena. In seguito, il Maestro si confrontò poco con i “mondi neri”. Innanzitutto quel cinema andava (da noi) esaurendosi. Terminava una stagione, languivano i generi. Estinto ingloriosamente il western con il dimenticabile Occhio alla penna di Michele Lupo nel 1980 (che è anche uno dei rari infortuni morriconiani: quandoque bonus dormitat Homerus), tramontati poliziotteschi mafiamovie pornonazi decamerotici commedie sexy e mondomovie e filoni dei sottofiloni assortiti, rimaneva l’horror nella sua ubiquità versatile. Dopo il capolavoro Buio Omega che nel 1979 chiude il decennio d’oro, Aristide “Joe D’Amato” Massaccesi firma il viscerale Antropophagus (1980) e Rosso sangue (1982) che vale il suo nome. Spuntano il discepolo di Argento Michele Soavi con il perturbante Deliria (1987) e tante altre belle cose, Lamberto Bava con i suoi macabri allestimenti mentre Fulci e Argento proseguono nel loro percorso variegato e – per il primo soprattutto - sempre più orrido e rivoltante. Nel nuovo secolo, mentre il cinema “visibile” approda ad una pericolosa deriva intimistico/patetico/sociologica e diviene sempre più televisivo, sotterranei e paralleli continuano a scorrere gli assurdi universi dei “mondi neri”, riferiti per lo più all’horror esposto in tutte le possibili forme e variamente contaminato, con un estremismo visuale e di contenuti che non risparmia alcuna abiezione e nulla lascia all’immaginazione: un deflagrare di atrocità, torture e torture porn, depravazione e follia epitomi di un passato con il quale obbligatoriamente confrontarsi. Splatter e gore insanguinano anche il western pulp Quella sporca sacca nera di Mauro Aragoni (2015), lunare nel paesaggio e ridondante nella violenza e con un ottimo e purtroppo inedito commento musicale di Antonio Manca. Anche il recente corto Bloody Fury (2023) di Jordan Incostant, musicato con talento da Di Bona & Sangiovanni, dispensa cruente efferatezze nel suo iperbolico omaggiare uno dei nostri generi più fortunati. Di contro alle rare reviviscenze del western, la cinematografia a vario titolo orrorifica prosegue il suo cammino con registi quali Fabio Salerno (divorato dai suoi stessi incubi), Giorgio Bruno, Ivan Zuccon, Federico Zampaglione (del quale, dopo gli ottimi Shadow e Tulpa, si attende The Well, che dovrebbe unire un’estetica tra l’hammeriano e il baviano all’oltranzismo visuale del new horror), Lorenzo Lepore, Raffaele Picchio (il suo Morituris, 2011, fu l’ultimo film censurato in Italia prima dell’abolizione dell’istituto censorio nel 2021), Mattia De Pascali (Il tuo sepolcro… la nostra alcova – Beyond the Omega del 2020 è “un horror fra i più estremi visti in Italia negli ultimi anni (ma mai gratuito) che si nutre di sesso, violenza e necrofilia,” secondo “Nocturno”: vedere per credere) (3); ed anche, su di un versante più “atmosferico”, Rossella De Venuto con il suo Controra – The House of Shadows (2014), “racconto di fantasmi e trame gialle”, (4), o Phobia (2023) di Antonio Abbate, “discomfort zone tra Il profumo della signora in nero e i complotti lenziani” (5). Cinema in prevalenza indipendente, autofinanziato o, come oggi si dice, indie, lontano dalla produzione e distribuzione ufficiali: ecco la differenza tra l’ieri –quell’ieri che Ferretti riporta in vita per noi- e l’oggi in cui il “genere” è confinato entro un’esistenza catacombale.
Ennio Morricone, uno degli interpreti più sensibili e completi delle molteplici anime del cinema in Italia tra i Sessanta e gli Ottanta e protagonista del nero strapaesano come il libro documenta, manca all’appello in questa cinematografia in limine tanto ricca di visionarietà crudele quanto modesta mediamente nella resa musicale. (Non si dimentichi che il Maestro è scomparso appena nel 2020 e dunque molto gli si sarebbe potuto ancora offrire; latita anche Donaggio, uno dei pochi superstiti della vecchia scuola, e che in certe tematiche ci sguazza; ogni tanto compare Marco Werba, un poco più giovane e ben radicato in quel humus. Ma i nuovi e spesso talentuosi registi “di genere” paiono accontentarsi di musiche standard, “industriali” ancorché magari funzionali). Il nuovo millennio lo vide scarsamente occupato nel cinema-cinema eccezion fatta per Tornatore, il penultimo Montaldo e qualche altro, magari fuori sede (Carion, Tarantino). Per contro, fu attivissimo in ambito televisivo e firmò partiture per fiction agiografiche: biografie di santi, pontefici, sindacalisti, benefattori, campioni dello sport; e Resistenza e foibe e abnegazioni generose e buoni sentimenti e bene che trionfa sul male, pelosa esaltazione del buon operare targata RAI pro aedificatione delle platee di prima serata. Ovviamente, lui se ne fregava dei contenuti, proseguiva nella sua ricerca, esperiva, inventava, sottolineava il Bene senza retoriche untuose e conferiva al Male il carattere di una grandiosa mistica rappresentazione (come ne L’ultimo dei Corleonesi, 2007: musica nerissima ed anche coraggiosa per un prodotto affogato nel grigio stinto della fiction – altra cosa fu La piovra, allora un poco ancora si osava anche in televisione; o nei 14 minuti della “Composizione sulla Resistenza” da Cefalonia, sintesi di effetti tensivi ed impegno civile): insomma, alla musica il compito di una “narrazione” espressionista e anabolizzante in contrasto col pacato raccontare per immagini delle televisioni di Stato e non.
Eppure il Maestro dagli Ottanta in su non aveva chiuso del tutto con le tematiche nereggianti: The Thing (John Carpenter, 1982: la fantascienza e l’orrore, archi gelidi, organo e synth per una sinfonia fosca che somatizza la greve oppressione, la perdita di umanità nelle raccapriccianti metamorfosi, l’urlo espressionista, l’attesa del nulla, gli abissi siderali di cronologie non-umane), Extrasensorial (Alberto De Martino, 1982: il doppio, con echi di certo De Palma, musica dolce ed insinuante, con bagliori sinistri), Rampage (William Friedkin, 1987: legal thriller & serial killer, partitura asciutta, disarmonica), il gangster noir State of Grace (Phil Joanou, 1990: suoni in bianco e nero, rarefatti e laconici: un nuovo vertice compositivo per una storia di mafia irlandese-americana ambientata nella Hell’s Kitchen newyorkese), La sindrome di Stendhal (Dario Argento, 1996, ancora l’impiego di una voce di bambina che asseconda la forma della passacaglia e genera nuovi incubi sonori), La sconosciuta (Giuseppe Tornatore, 2006: il lato dark dell’autore di Nuovo Cinema Paradiso, assecondato da una partitura piena di idee, cromatismi cupi e sonorità tra l’herrmanniano e il metal, senza contare la bellissima nenia: a quasi ottant’anni, il decano dei nostri musicisti per il cinema affrontava le nuove fatiche con un animo e una creatività che sarebbero parsi straordinari in un giovane), The Hateful Eight (Quentin Tarantino, 2015: tragedia elisabettiana e claustrofobia in chiave postwestern). Per limitarci ad un primo elenco e non sovraffollare il testo. Tornando a Tarantino, con lui il compositore chiude idealmente e circolarmente la sua carriera con un ritorno al genere dal quale aveva preso le distanze e al quale tanto doveva. Banditi, fischio, incudini, fruste, chitarre elettriche e non, armonica, cori, insomma tutto l’armamentario che aveva scardinato il commento sinfonico-folk di innumerevoli pellicole d’oltreoceano, ecco creato un nuovo mood, una tessitura funerea percorsa dalla fissità allucinata degli archi, dal timbro scuro delle tube, dall’imponenza greve degli ottoni, dalla glacialità del synth: il poema al nero di “L’ultima diligenza per Red Rock”, l’insostenibile immobilismo dinamico di “Neve”, i dissonanti “Sei cavalli” e “Raggi di sole sulla montagna” e “La puntura della morte” ove sfumano i confini tra “applicato” ed “assoluto”, l’oasi di rarefatto lirismo “militare” di “La lettera da Lincoln”, tromba e orchestra per l’unico momento consonante in una partitura abrasiva.
Marco Ferretti passa in rassegna i 56 lungometraggi secondo lo schema Trama-Descrizione-Musica. Ne esce un dizionario cine-musicale da leggere per puro diletto e/o consultare al bisogno: un bel dittico con il precedente "Così nuda così violenta" di Alessandro Tordini (2016). Opere sino a un decennio fa assenti nella pur folta editoria filmica e che segnalano un importante cambio di rotta ovvero dare alla musica quel che è della musica, senza lesinare sull’imprescindibile contesto che tuttavia dovrà poi acquattarsi in corner. Scrivere di cinema e di musica non è semplice, occorre inventare i correlativi linguistici adeguati, operare una impervia transcodificazione. Ferretti supera il cimento in virtù di una prosa allusiva che evoca la suggestione delle trame, la pregnanza delle immagini, l’ambiguità fascinosa dei suoni: le “note monofoniche” di Amanti d’oltretomba, la “camaleontica canzone” (la “Ballata di Hank McCain”) da Gli intoccabili di Montaldo, il “poema d’amore in note” che è Metti, una sera a cena, il “tema facile, ironico e ostinato […] con cromatismi mai assoluti” di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, le “melodie storpie” in La classe operaia va in paradiso, la “alienazione in note” in La proprietà non è più un furto, “l’astratta partitura [di] strutture irrelate per ciascuno strumento” per L’uccello dalle piume di cristallo, la “continuità di distorsioni ed evocazioni, fiati scordati e lamenti per dar luogo a un sentore di angoscia sottopelle” in Il gatto a nove code, mentre Milano odia: la polizia non può sparare “distilla pathos in note”, e “un macabro crescendo di «multiple»” scandisce Macchie solari. Le schede sono concise ma di elevato peso specifico, di rapida e densa lettura. Più estese ed analitiche quelle riservate alla “trilogia degli animali” argentiana e a quella “della nevrosi” di Elio Petri, con puntuali disamine tematico-stilistiche e delle interrelazioni musica/immagini: un atto dovuto alla genialità dei due cineasti. L’autore ci accompagna in questo intrigante viaggio attraverso il nostro cinema d’antan e la musica del suo maggiore compositore, illumina le zone buie di una discografia poco e mal nota, rinnova la memoria di una stagione lontana ed epifanicamente propizia la recherche du temps di ciascuno.
Potrebbe bastare (ed avanzare). Ma il libro offre assai di più, imbandisce una beata mensa di raffinate interminabili portate delle quali mai veniamo sazi. Se l’analisi dei film e relativa musica costituisce il piatto principale, entrée e plateau de desserts sono ben più di contorni e aggiunte. Fuor di metafora, due capitoli offrono un profilo globale delineando il percorso evolutivo morriconiano con lapidarie azzeccate definizioni là dove si parla di “linguaggio efficace sul piano drammaturgico e innovativo sul piano musicale”, o di personale evoluzione “«rifondata» sulla classicità”; o ancora di “vocabolario di suoni destinati ad essere un riferimento ineludibile per i compositori di ieri e di oggi”. L’autore si mantiene fedele alla linea interpretativa proposta da Sergio Miceli nella sua monografia, della quale offre un digest apprezzabile. Più personali le analisi audiovisive di Un tranquillo posto di campagna, La corta notte delle bambole di vetro, L’ultimo treno della notte; del rapporto musica/nevrosi in Petri; del legame con il cinema di genere accostato senza pregiudizi estetici, “usato” piuttosto come laboratorio sperimentale. Tornando a Petri – uno dei sodalizi più creativi -, si evidenzia il nesso fra struttura musicale e assunto ideologico. In Indagine… “la tonalità è destrutturata attraverso il cromatismo”, ovvero la nevrosi del potere incarna “a sua volta la crisi di un’istituzione musicale, quella della tonalità”. In seguito, la crisi del suono nella partitura a tratti rumoristica de La classe operaia, e la nevrosi della melodia che rispecchia quella del denaro in La proprietà non è più un furto. Ecco le cose che ci piace leggere, pungoli per comprendere, e irrobustire i piaceri della visione e dell’ascolto.
Il contorno si allarga di poi al giallo/thriller prima e dopo il 1970, con Argento a sedere virtuoso nel mezzo: piccola cronaca di registi, titoli e topoi e, per la musica, una ”«sintonia» tra cinema e compositori” che “si è conclusa a metà degli anni Ottanta quando produttori e registi hanno preferito ricorrere a brani già editi di cantanti e gruppi musicali”. Più che altro, il nostro cinema di genere tirava a campare (il che, diceva qualcuno, è sempre meglio di tirare le cuoia), ridimensionato sul piano quantitativo e talvolta anche qualitativo, e i compositori si “applicavano” a tematiche più “normali”, diciamo pure più innocue. Inoltre, mediamente i registi tendevano ad attenuare il protagonismo della musica a favore di narrazioni più asciutte, o le attribuivano funzioni indirette, spesso di mera messa a fuoco (epoche, luoghi) con il conseguente ricorso a materiali preesistenti, canzoni per lo più, in forme assai epidermiche, avvalorando l’opinione di Petrassi (citato da Ferretti) sulla musica cinematografica come puro arredamento sonoro (ma non quando la “canzone” diventa collante narrativo legato alle vicende e ai vissuti, come “Amapola” in C’era una volta in America). Ma la figura del compositore “specialista” rimaneva un punto fermo. Anche se nulla sarà più come prima, cominciava l’era del “«pudore espressivo» con la conseguente riduzione delle esposizioni e delle funzioni drammaturgiche assegnate alla musica”, come osservato da Sergio Miceli (4). Ed anche il cinema ne uscì castigato, almeno nei canali distributivi più visibili ed accessibili.
Il banchetto diviene luculliano con il capitolo, “Breve storia della musica per il cinema di genere”, cavalcata selvaggia e restless attraverso i generi cinematografici e relativi compositori vale a dire, per un verso o per un altro, in forme evidenti o mascherate, tutti. Sfilano tutti o quasi, democraticamente, grandi minori minimi e insospettabili (come Renato Rascel). E ancora, un elenco smisurato di titoli, molti mai uditi (come Sexual Aberration di Bruno Mattei, o Si può fare molto con sette donne di Fabio Piccioni), biografie, informazioni collaterali sui mondi sommersi della popular e film music. Un enciclopedismo che ha un precedente nel già ricordato Tordini, del quale il capitolo in oggetto può considerarsi un (rad)doppio speculare e necessario. Si prende coscienza, non senza sgomento, di una vastità abissale. Un mondo criptico, ctonio e affascinante, come sempre quando si trascorre dalla superficie a tutti visibile alle profondità scandagliate da pochi palombari. (Se poi si varcano i confini nazionali e si guarda all’Europa, al mondo, a quel punto sarà l’abisso a fissare noi). Che in una tale vastità ci scappi qualche omissione o inesattezza, ci sta. Parlando di Piovani, non viene menzionata la collaborazione con Fellini. Le musiche di Deliria sono attribuite a Stefano Mainetti (che ha curato le musiche di scena teatrali insieme a Guido Anelli) mentre sono di Simon Boswell. Per pochi dollari ancora non è di Morricone ma di Ferrio (un brano del primo fu utilizzato abusivamente). La canzone “Se telefonando” viene inserita negli arrangiamenti senza precisare che il Maestro ne scrisse anche la musica; di alcuni film di Alberto De Martino (Ok Connery, Roma come Chicago) si ascrive la score al solo Nicolai, mentre una parte fu scritta da Morricone. Distrazioni emendabili nelle successive ristampe, ammesso che ve ne siano essendo l’argomento peregrino (e poi, oggi, i libri vivono l’espace d’un matin).
Assolutamente da rivedere l’editing, trascurato al massimo: troppi refusi e omissioni-ripetizioni di vocaboli e formulazioni sintatticamente incerte come, alla p. 365, “Eclissato dai film politici di Petri, Un tranquillo posto di campagna è una pellicola da riscoprire [nel: integrazione nostra] la sintesi audiovisiva che il regista e il compositore suggellano nelle note del Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza”. Che dire poi di “Tale cinematografia commerciale e popolare che ha fatto ricorso di elementi comici, fantastici, violenti o volgari non ha mai goduto dei favori degli addetti ai lavori […]” (p. 376)? Ora, nessuno si sogna e si permetterebbe di porre in dubbio la padronanza linguistica di Marco Ferretti: ma quelli della Shatter dovevano essere più vigili, la bellezza di un libro è anche la sua “forma”, elemento sostanziale.
Poiché anche l’occhio vuole il suo, ecco un artwork accattivante e mirato. Al primo impatto siamo in pieno Giallo Mondadori: sfondo giallo, cerchio rosso con disegno incorporato. Ma il giallo è chiazzato di rosso, la circonferenza è irregolare con sbavature esterne e soprattutto interne. Dentro l’oblò, pentagrammi accatastati, carta ingiallita e un poco gualcita, in basso una chiazza di sangue che si espande. I caratteri sono essi pure funzionali, un courier che richiama i verbali stesi alla macchina per scrivere negli uffici di questura mentre il killer perpetua le sue mattanze: bianchi su sfondo rosso per l’autore, gialli su base nera per il titolo. Giallo (il genere), rosso (gli omicidi al sangue), l’orrore tenebroso dell’oscurità: una tavolozza evocativa ed essenziale, “si lavora in realtà con pochi colori” messi al posto giusto, diceva Picasso.
"Dissonanze per un delitto" è un approfondimento valido, con parecchie luci e qualche ombra. A tratti sin troppo debitore verso opere precedenti, regala poi guizzi di originalità, giudizi acuti, spunti analitici d’interesse, insomma vale la lettura. Lettura iperspecialistica certo, riservata ai cultori della Settima e Ottava arte e, naturalmente, a coloro che prediligono la musica del maestro Morricone. Ma non preclusa a tutti gli altri, occasione anzi preziosa di apertura a nuovi mondi, complici i succosi apparati bibliografici: bibliografia e sitografia per la parte generale, discografia essenziale e filmografia per quella monografica con i crediti dei singoli film con la sola (e non spiegabile) omissione del cast.
Da tenere in conto, per chiudere, la compatta Prefazione di Antonio Tentori, uno dei massimi esperti del cinema di genere nostrano, che si sofferma sulla “musica di Ennio Morricone nei gialli-thriller italiani degli anni Settanta”, esplora talune soluzioni audiovisive e sottolinea il “contributo artistico” del Maestro, “fondamentale per comprendere nella sua interezza” quel filone tanto particolare e così nostro.
(1) SERGIO MICELI, Parola di musicologo, in ENNIO MORRICONE, Inseguendo quel suono. La mia musica, la mia vita. Conversazioni con Alessandro De Rosa, Milano, Mondadori, 2016, p. 391.
(2) ID., Morricone, la musica, il cinema, nuova ediz. a c. di Maurizio Corbella, Milano, Casa Ricordi – Lim editrice, 2021, pp. 283-285 e 419-421.
(3) https://www.nocturno.it/movie/il-tuo-sepolcrola-nostra-alcova/ (ultimo accesso: ottobre 2023).
(4) https://www.nocturno.it/movie/controra/ (ultimo accesso: ottobre 2023).
(5) https://www.nocturno.it/movie/phobia/ (ultimo accesso: ottobre 2023).
(6) SERGIO MICELI, Musica per film. Storia – Estetica. Analisi – Tipologie, Milano, Casa Ricordi-LIM editrice, 2019, p. 368.