Nagasaki: Memories of My Son
 Ryuichi Sakamoto
Ryuichi Sakamoto
Nagasaki: Memories of My Son (Haha to Kuraseba, 2015)
Milan 399 852-2
28 brani – Durata: 61’00”
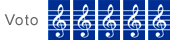
Molte anime e altrettante fonti di ispirazione convivono in Ryuichi Sakamoto, senza dubbio il più importante compositore giapponese contemporaneo; e anche a volerci limitare alla sola produzione per il cinema, sono proprio questa poliedricità, questo atteggiamento aperto a diverse sollecitazioni, ad avergli consentito un così vasto consenso di pubblico e ad averne fatto oggetto di attenzione internazionale da parte di registi di ogni latitudine, da Bertolucci ad Almodovar, da Abel Ferrara a Volker Schloendorff.
Eppure la sensazione è che a questo punto del proprio itinerario artistico, il maestro nipponico attraversi una fase di ripiegamento intimo, personale, di rivisitazione del passato sia proprio che delle proprie radici, che lo conducono a dare il meglio di sé non tanto in ambiziose e sonnacchiose superproduzioni straniere tipo The Revenant di Iñàrritu, quanto in alcune significative, coinvolgenti pellicole provenienti dal suo paese. Nagasaki: Memories of My Son, di un veterano del cinema giapponese come Yoji Yamada (classe 1931) può considerarsi a buon diritto un manifesto di questo particolare momento della carriera del musicista. A settant’anni esatti dalle atomiche di Hiroshima e Nagasaki, il film ha infatti per protagonista una donna la cui esistenza è stata sconvolta dalla guerra prima e dalla bomba poi, che le han portato via marito e figli. Rifugiatasi nel lavoro per sfuggire alla disperazione e alla solitudine, Nobuko – questo il suo nome – comincia a ricevere le “visite” del fantasma del figlio più piccolo, Koji, con il quale si lascia andare a ricordi della felicità passata, da un lato amplificando così il devastante strazio delle sue perdite, ma dall’altro cogliendo anche l’occasione per ripensare ad alcuni suoi rapporti personali tuttora irrisolti.
Un dramma psicologico, insomma, dove lo struggimento e il sentimento della pena rimangono sempre circoscritti nell’alveo di quel pudore sentimentale ed espressivo, di quella insormontabile e rigorosa dignità che è uno dei tratti distintivi di quel popolo e della sua tormentata storia.
La partitura di Sakamoto si muove lungo un orizzonte espressivo ben definito, dal quale sono bandite spigolosità moderniste o vezzi spudoratamente citazionistici, altre volte presenti nei suoi lavori. L’organico prevede una vasta sezione di archi, un pianoforte, e alcuni legni in funzione solistica, e la struttura complessiva appare quella di un immenso adagio suddiviso in molte sezioni a volte brevissime. L’eloquio quieto, il fraseggio pacatamente lirico dell’iniziale “Memories of my son” testimonia l’assenza di una conflittualità esasperata, urlata, sentimenti estranei a questa cultura, affidando piuttosto ai successivi “B29” e “August 9th, 11:02 am” il compito di restituire, con terribile, icastica semplicità e appena rielaborati, i suoni e le voci della catastrofe abbattutasi sulla città in quell’estate del ’45. Anche l’elemento soprannaturale è risolto con un’accentuazione visionaria della componente lirica, come attestano i flautandi dei violini in “Ghost”, mentre il pianismo sommesso di “At the graveyard”, “78 RPM” e “How are you?” rimanda ad una concezione quasi minimalista.
Ma ecco che a partire da “Koji’s room”, negli sviluppi armonici e nel fraseggio degli archi si fanno largo altri modelli che sicuramente Sakamoto ha presenti; a cominciare da quello di Gustav Mahler, nei cui adagi (Quinta, Sesta e Nona Sinfonia soprattutto) e alla cui desolazione il compositore sembra senz’altro guardare. Peraltro il decorso melodico è sempre molto semplificato, lineare, quasi ripetitivo, come nel pianoforte che fa eco al mesto disegno tematico del clarinetto in “Raindrops” o nelle limpide, accasciate armonie di sapore quasi schubertiano in “Machiko” e “Giving up”; naturalmente Sakamoto non rinuncia ad una fase di rielaborazione del suono che è tipica di tutta la sua attività di esecutore e compositore, come nel pianoforte “trattato” di “I can’t take it”, non facendo che aggiungere intensità emotiva ad una qualità di suono calibrata in ogni minimo dettaglio.
Si giunge così ad uno dei vertici dello score, “Killed in the war”, dove l’impasto degli archi assume valenza di una tragica, funerea densità risolta in una serie di severe deviazioni politonali. Se “Soul of the dead brother” e “MP” sono alcune delle rare concessioni – e dunque ancor più efficaci drammaturgicamente – al sound elettronico, in cui peraltro Sakamoto è maestro, si torna alla tranquilla disperazione degli archi in “Koji’s aria” prima di una “Pastoral” esemplare, che ripropone il clarinetto nel tema di “Raindrops” ma accompagnato dal lieve, impalpabile pulsare ritmico degli archi.
Archi che in “Memories of my son – PF” declinano scopertamente le proprie radici mahleriane, così come quelle più neoclassiche in “Memories of my son – Requiem”; e se “Funeral” è un brano per piano solo di esemplare, icastica asciuttezza, il loro accorato e nel contempo solare fraseggio in “A hug” è un perfetto esempio di come Sakamoto descriva musicalmente la tragedia con tonalità che non sfiorano mai l’enfasi ma si raccordano piuttosto ad un istintiva, catartica pietas. Vale anche per il trasognato “Dr. Kawakami” la cui prima parte si svolge in un severo, cupo registro grave mentre la seconda, sul registro più acuto dei violini, torna a proporre alcuni sforamenti dissonanti che a loro volta si rifanno nuovamente ad alcuni passaggi mahleriani (si pensi allo spettrale adagio dell’incompiuta Decima).
Cantato per voce maschile e coro, “Nobuko” – dedicato alla protagonista – è una pagina di rasserenata riconciliazione con la vita, mentre “Machiko’s aria” per pianoforte solo è una sorta di concentrato, complesso “studio” dai risvolti armonici moderni. Chiude la riproposizione dei temi principali “Nagasaki: memories of my son – Title W.PF” per piano e archi, all’insegna di quella pacificazione interiore che è il tratto distintivo di questa bella partitura: laddove la spinta a rialzarsi e ad andare avanti non significa dimenticare le strazianti ferite ancora aperte ma, al contrario, rielaborarle e superarle con una nuova e superiore cognizione del dolore.