Sicario: Day of the Soldado & The White King

Hildur Guðnadóttir
Soldado (Sicario: Day of the Soldado, 2018)
Concord Records
14 brani – Durata: 42’10”
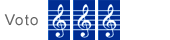

Joanna Bruzdowicz
The White King (2017)
Silva Screen Records SILCD1563
30 brani – Durata: 39’02”
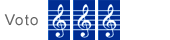
Oltre a due nomi di ardua memorizzazione e ancor più impervia pronuncia, Hildur Guðnadóttir e Joanna Bruzdowicz hanno altri elementi in comune, a parte quello – evidente – di contribuire ad arricchire la sempre più folta e interessante pattuglia di compositrici per il cinema. Innanzitutto provengono entrambe dal nord Europa: islandese la prima, 35enne, già a lungo collaboratrice di Jóhann Jóhannsson e firmataria con lui di una delle sue ultime score, il biografico-religioso anomalo Maria Maddalena di Garth Davis; polacca e più anziana di ben 40 anni l’altra, approdata al cinema sin dal 1980, da tempo stabilitasi in Francia e nota in particolare per la scontrosa e aspra partitura di Senza tetto né legge di Agnès Varda, Leone d’oro a Venezia nel 1985.
Inoltre ambedue sono principalmente attive nei propri paesi come prestigiose esponenti della musica classica contemporanea: la Guðnadóttir è un’acclamata violoncellista che però ha rapidamente esteso interessi e repertorio al vasto e irrequieto panorama musicale del proprio paese, collaborando con band elettroniche d’avanguardia come i Pan Sonic e dimostrandosi molto interessata nei propri album da solista alle più avanzate e sofisticate ricerche tecnologiche sul suono. Per vocazione e generazione, la Bruzdowicz è invece una figura più radicata negli ambienti delle avanguardie storiche novecentesche, avendo studiato tra gli altri con Nadia Boulanger, Olivier Messiaen e Pierre Schaeffer, ed è autrice di numerosa musica sinfonica e cameristica oltre che giornalista e critico musicale.
Le analogie però si arrestano qui, e le due partiture in oggetto non potrebbero dimostrarlo meglio.
Soldado, l’incendiario sequel del cupissimo e disperato Sicario di Denis Villeneuve firmato da Stefano Sollima, è a tutti gli effetti un manifesto programmatico di “anti-musica”: posto ovviamente che per “musica” s’intenda una dimensione nettamente separata dagli effetti sonori e più in generale da una polarizzazione rumoristica del paesaggio acustico. Ma sbaglierebbe chi giudicasse aprioristicamente questo risultato come qualcosa di scarso interesse. In realtà sono caratteristiche ricorrenti nelle partiture filmiche dei compositori di quelle latitudini, e lo erano in particolare del compianto Jóhannsson, che proprio in Sicario edificava una imponente architettura di “Industrial music” fondata su ossessive cellule percussive e rimbombanti, inseguendo una spazialità tridimensionale del suono che si trasformava rapidamente in autentico inferno dei sensi: in ciò perfettamente coerente con l’universo ultradark e iperviolento del film. E poiché Soldado esaspera ulteriormente queste connotazioni, intorno al protagonista spietato e disperato interpretato dal gigantesco Benicio Del Toro, ecco che la compositrice riprende quella “forma” e quelle caratteristiche se possibile estremizzandole ancor più. Ne esce una successione di tracce ipnotiche, iterative e colossali, fondate ancora sull’utilizzo feroce della percussione (“Attack”, “Start of war”) in una sorta di distorsione allucinatoria della “musica di guerra”. L’intento respingente, ostile, soffocante di questo soundtrack non potrebbe essere più esplicito: interminabili pedali bassi, lamenti acuti e strascicati, cluster rimbombanti e freddamente aggressivi sorreggono l’unico elemento mobile della score, cioè la percussione. E sorprende in tal senso che una solista di prestigio come la Guðnadóttir abbia licenziato una partitura che rifugge dalla benché minima traccia di invenzione melodica o leitmotivica; qui il leit-motiv è, in realtà, il peso, lo spessore, la densità stessa del suono.
Il che ovviamente non significa appiattimento espressivo. Vi sono frangenti in cui la materia sonora sembra acquietarsi (“Miguel takes money”) e quasi dissolversi in effetti fantascientifici che approdano a trasparenti accordi di archi (“Santa Claus”), altri dove la relazione con il precedente lavoro di Jóhannsson si fa più diretta (“The kidnap”); e c’è anche un sapiente gioco di contrasti tra registro grave (il ribollente “Convoy”) e registro acuto o sovracuto, come nell’improvvisa, celestiale apertura di “Alejandro saves Isabelle”, basata su lunghe frasi degli archi inframmezzate da altrettanto lunghe e sospensive pause. Si tratta di una catarsi comunque provvisoria in un lavoro che punta diritto agli inferi (la terribile “The execution”), e la cui inafferrabile, gelida e oscura potenza risiede proprio nella disturbante intensità del linguaggio adottato.
Siamo agli antipodi, com’è facile immaginare, con la partitura di Joanna Bruzdowicz per una singolare produzione britannica firmata da due giovani registi, la britannica Alex Helfrecht e Jörg Tittel, quest’ultimo figlio della compositrice. Nel solito futuro distopico che sembra ossessionare in particolare la cinematografia del Regno Unito, vi si narra di un ragazzino che vive in un territorio dominato dalla dittatura ed escluso dal resto del mondo, il quale decide di battersi per la libertà propria e della sua famiglia. In netta opposizione a ciò che qualunque compositore medio hollywoodiano avrebbe fatto con un simile argomento (da Jablonsky a Djawadi, da Tyler Bates a Balfe, tanto per capirci), la musicista polacca si affida ad un organico ristrettissimo dove è protagonista assoluto il quartetto d’archi, affiancato da percussioni di caricaturale militarismo (“Homeland history – Opening titles”), ed al quale delega un tema tenero e semplice, di matrice inequivocabilmente slava, dal sapore bucolico e innocente; e “Innocence” s’intitola appunto una delle tracce più suggestive e struggenti, pur nella sua brevità. In grado di padroneggiare materiali colti non meno che quelli popolari, la Bruzdowicz alterna pagine come “Village Folk”, anche questa brevissima, sorta di “square dance” contadina, ad altre come “The Homeland is glorious”, la cui incerta coralità e il suono volutamente piatto alludono al lato inesorabilmente ridicolo (si ascolti anche “The twins”) che – oltre a quello tragico – reca in sé qualsiasi dittatura.
Sono tracce episodiche, ma significative, collocate però dentro una partitura sobriamente e nobilmente lirica e malinconica, caratterizzata da uno spiccato cromatismo e da echi inequivocabilmente mitteleuropei, filtrati da un camerismo schiettamente novecentesco. Tali appaiono “They got to you” che rallenta il tema principale sino a virarlo in nenia funebre, o “It’s gonna be okay” e “Broken heart”, o ancora “The long walk”, che ha quasi le movenze energiche di un quartetto bartokiano. Anche in questo caso, sia pure su un piano radicalmente diverso dalla Guðnadóttir, si osserva una ricercata elaborazione dei contrasti espressivi: e quindi risaltano ancor più momenti di netta, quanto contenuta e prosciugata, avanguardia, soprattutto nell’utilizzo della percussione che predilige sempre il ritmo tambureggiante e processionale di una grottesca parata (“Asshole”, “Kill the cat”, “Tank chase”). Ma a prevalere è un sentimento di arida solitudine, espressa dal canto dei solisti (”We found it”) o da quello dei celli distesi in un raro fraseggio all’unisono (“Pickaxe”); e la concentrazione espressiva si fa massima in dirittura d’arrivo, con “My son, my son” che vede i violini vagare sperduti sul sostegno di celli e bassi, o “Reunion”, dal drammatico fraseggio contrappuntato dal rullare dei tamburi: sino ad approdare alla serena ricapitolazione degli “End credits” che si conclude tra severi rintocchi di campane.
Due visioni del mondo – e della musica – ampiamente distanti dunque, quelle di Hildur Guðnadóttir e Joanna Bruzdowicz: ma, ed ecco un altro fattore che le connette, decise ad esprimersi con mezzi del tutto personali e decisamente inusuali.