Fences
 Marcelo Zarvos
Marcelo Zarvos
Barriere (Fences, 2016)
Sony Classical 886446202341
13 brani + 4 canzoni - Durata: 59’41”
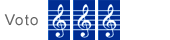
Alla sua terza regia, che come le due precedenti (Antwone Fisher e The Great Debaters - Il potere della parola) affronta tra realtà e finzione i temi cruciali dell’integrazione razziale, Denzel Washington trova sulla propria strada, dopo Mychael Danna e James Newton Howard, il brasiliano Marcelo Zarvos, un compositore delicato e sensibile che sembra avere per le vicende di emarginazione e riscatto (vedi il recente Wonder) un tocco particolarmente felice, senza peraltro cadere nelle trappole di un mieloso sentimentalismo o di facili manierismi folkloristici.
Questa impostazione passa innanzitutto per una semplificazione francescana dell’organico strumentale impiegato: pianoforte, pochi archi (magari addolciti dalla sordina, come in “Gabriel’s trumpet”, dove ovviamente non c’è traccia di tromba e il titolo sembra piuttosto omaggiare il Morricone del “Gabriel’s oboe” di Mission), assenza quasi totale di fiati e percussioni. È improprio parlare di minimalismo, etichetta che ormai viene appiccicata a qualsiasi partitura che non sfoggi esibizioni di sinfonismo muscolare: Zarvos lavora infatti di cesello sulle armonie e sulle aggregazioni diatoniche, e la sua semplificazione riguarda soprattutto la struttura interna di ogni brano. Spira una calma olimpica in questa score (cui si affiancano brani d’epoca di artisti come Gene DePaul o Sammy Cahn, e voci soul o gospel come Jimmy Scott, James Cleveland e Dinah Washington), a ovvio e netto contrasto con il dramma familiare e sociale che si consuma sullo schermo: e la severa, composta e pudica mestizia che la attraversa tutta viene espressa con tocchi sommessi ma intensi. È il caso del “Cory’s theme”, che all’eloquio pacato di archi e piano aggiunge i tocchi della celesta, o di “Alone at the bar”, egualmente rarefatto nelle sonorità e pensoso nello spirito, ma gravato dalle ombre di una tristezza che in “You got the devil in you” si fa particolarmente cupa e drammatica, con il contrasto fra celli e bassi da un lato e violini flautandi dall’altro.
“Womanless man” tuttavia ripropone l’estatica, quasi atarassica immobilità degli archi divisi oscillanti tra pochi accordi ricorrenti e sui quali dondolano pigramente pochi accordi del piano, mentre l’assolo di quest’ultimo in “Fences” ha l’evanescenza di tocco di un notturno chopiniano su un lattiginoso accompagnamento di archi e legni. Sonorità più fredde e sospese attraversano “Troy’s story”, ma sempre con quel senso di interrogativa incompiutezza che caratterizza tutta la partitura: così, il “Rose’s theme” dimostra più di un’analogia strutturale e melodica con il “Cory’s theme”, lasciando a “Troy could do nothing for her” il compito di rappresentare il momento forse più anomalo della score, con le sue dissonanze vitree e distorte, e le inquiete pulsazioni in profondità.
L’andatura lenta, strascicata degli archi in “Confession” ha poi qualcosa di intimamente funebre, che - dopo i toni più distesi del piano in “City hall” - il conclusivo “God’s closet” si incarica di riprendere in forma di vero e proprio radicale epitaffio, con le sonorità che cercano quasi di occultarsi e il pianoforte lasciato solo a levare arabeschi di disarmante semplicità.
Una partitura, questa di Zarvos, che dimostra come dicevamo la propensione del compositore per atmosfere rarefatte, piene di pudore espressivo e di lirismo sotto traccia: il tutto ovviamente sempre sul filo del rasoio di una certa monotonia, che il musicista riscatta in virtù di una sincera e umanissima ispirazione malinconica.