Arrival
 Jóhann Jóhannsson
Jóhann Jóhannsson
Arrival (Id., 2016)
Deutsche Grammophon 479 6782
20 brani – Durata: 56’20”
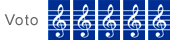
La prematura scomparsa di Jóhann Jóhannsson, avvenuta lo scorso febbraio ad appena 48 anni, ha privato la scena cinemusicale mondiale di uno dei suoi esponenti più coraggiosi e stimolanti, appartenenti a quella “scuola del profondo Nord” che ci ha dato altri talenti come Söderqvist, Örvarsson, Kantelinen, Göransson e altri. Tutte personalità caratterizzate da un’accesa vocazione sperimentale, d’avanguardia, unita però ad una particolare forma di neolirismo quasi mistico, contemplativo, che fa delle loro partiture esperienze d’ascolto irripetibili e simili a quelle di nessun altro.
Jóhannsson era fra questi forse la figura più avanzata e innovatrice, sia per la sua esperienza nell’universo dell’”electro-post-rock” di ricerca, orientato all’utilizzo delle più disparate fonti di suono acustiche ed elettroniche, compresa la voce umana, sia per la oggettiva vicinanza e comunanza di interessi con alcune figure delle avanguardie storiche del ‘900, in primis Karlheinz Stockhausen. Non è un caso che proprio per questa partitura il compositore utilizzi, accanto alla City of Prague Philharmonic, quell’ensemble danese Theatre of Voices già caro proprio al compositore tedesco, con il baritono Paul Hillier, il soprano Else Torp e artisti come Robert Aiki, Aubrey Lowe e il violoncellista Hildur Guðnadóttir, integrando nel suo spartito anche alcune soluzioni della leggendaria vocalist americana d'avanguardia Joan La Barbara. Del resto Jonathan Broxton, nella sua puntuale analisi di questo lavoro su “Movie Music UK” del 15 novembre 2016, osservava le strette parentele proprio tra la partitura di Arrival e la composizione “Stimmung” di Stockhausen, risalente al 1968, scritta per sestetto vocale e considerata un manifesto dell’estetica dell’autore di “Gruppen” e “Kontakte”.
Nel cinema postmoderno e irrequieto del canadese Denis Villeneuve il musicista islandese aveva trovato un terreno particolarmente fertile per la propria ricerca, come dimostrano le score di Prisoners e soprattutto Sicario, e come avrebbe sicuramente confermato Blade Runner 2049 se la commissione non gli fosse stata tolta dal regista per “divergenze di vedute artistiche” e affidata al duo Zimmer-Wallfisch… Ecco allora che Arrival resta, alla lettera, il punto d’arrivo, l’approdo naturale e più ambizioso di questo breve ma intenso sodalizio, un manifesto di fantascienza adulta e umanistica che, a mezzo secolo dall’uscita di 2001 odissea nello spazio, ci appare oggi come l’esito più prossimo e ispirato alla meditazione kubrickiana sulle possibilità di contatto fra noi e altri universi.
L’intuizione più acuta e significativa di Jóhannsson consiste nell’aver posto qui la “comunicazione” al centro del proprio lavoro, esattamente come lo è nel film. Solo che in quest’ultimo essa si esplica attraverso segni, grafemi, forme, mentre nella score e nel sound design della pellicola essi vengono fatti corrispondere a “voci” variamente e imprevedibilmente manipolate. L’operazione si presenta affascinante, di grande suggestione anche per la quantità e qualità di influenze che Jóhannsson dichiarava apertamente di subire: ad esempio quelle dei cosiddetti “spettralisti”, una corrente delle avanguardie musicali a cavallo tra gli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, e che aveva tra i suoi principali esponenti i capiscuola francesi Gérard Grisey e Hugues Dufourt, il romeno Horatiu Rădulescu e l’italiano Fausto Romitelli. Lo spettralismo, cui non erano estranee anche speculazioni di natura squisitamente filosofica, partiva dall’analisi dei fenomeni fisici correlati al suono, includendovi sia gli strumenti che le voci, ma anche i rumori prodotti dall’ambiente, e utilizzando il tutto per la composizione, basandosi inoltre sul fattore temporale e arrivando quindi a dilatazioni potenzialmente indefinite della durata dei brani.
Ed è proprio l’utilizzo delle voci, manipolate sino a renderle irriconoscibili ma pur sempre intelligibili nel profondo, al centro di Arrival. Attraverso una sillabazione meticolosa e una vasta gamma di artifizi fonetici richiesti ai suoi solisti in sede di emissione, Jóhannsson evoca magistralmente un paesaggio acustico snervante e insieme fascinoso, ancestrale, nel quale effetti vocalizzanti inediti (”Arrival”, “Heptabod B”) si allineano a comporre un “sistema” comunicativo inconsueto ma non perciò meno espressivo e significante. In tal senso, ecco rivelarsi utili proprio la lezione di Stockhausen (“Hydraulic lift”) e le esperienze dalla La Barbara (“Decyphering”, “Rise”) in termini di scomposizione e plasmarsi della voce umana in nuove e inedite commistioni; che in ogni caso il compositore sostiene con l’ausilio di sezioni della City of Prague (gli archi in “Transmutation at distance”, i fiati di “Xenolinguistics”, i lunghi accordi in crescendo di “Around the clock news”) e dell’elettronica prevalentemente in un ruolo percussivo, spinto sino ad un’ipnotizzante ossessività (”First encounter”, periodicamente interrotto da un potente, apocalittico inciso).
L’alternanza e/o la giustapposizione dei due componenti principali – voce “campionata” e suono acustico/digitale – crea progressivamente quella doppia anima che è il fulcro emozionale della partitura. Ampie frasi di vasto spessore sonoro o interventi strumentali urticanti (“Ultimatum”, “Xenoanthropology”) si aggiungono a balbettii, sussurri, versi gutturali, lamentazioni (“Non-Zero-sum-game”) o, all’opposto, cori angelicali (“Escalation”) e magari brevi quanto struggenti assoli di violoncello, mentre gli archi si accendono in improvvisi fremiti e le percussioni accelerano bruscamente nei momenti d’azione (ancora “Ultimatum” e “Escalation”). Queste presenze più riconoscibili contribuiscono ad interrompere, ma anche accentuare, il senso di isolamento e di estraneità comunicato dal rimanente della score, che defluisce lentamente in un alveo quasi mistico, certamente soprannaturale, nel quale l’incolmabile lontananza che ci separa da quelle “voci” (“Kangaru”) sembra davvero risalire alla notte dei tempi, trasportandoci da un irraggiungibile futuro ad un non meno irrecuperabile passato remoto. Dunque una partitura che lavora appunto sul tempo, oltre che sullo (e nello) spazio e – non dimentichiamolo – sulla grande importanza dei silenzi, in ciò non solo ponendosi come esoterica e stregante esperienza d’ascolto ma anche cogliendo in pieno il messaggio e la valenza interiori del film, che certo appartiene a quel filone di “fantascienza adulta” e riflessiva iniziato proprio mezzo secolo fa con il capolavoro di Kubrick.
Insieme all’horror sui generis Madre! di Darren Aronofsky e a due biografie diversamente anticonformiste come quella religiosa di Maria Maddalena di Garth Davis e quella laica del velista-avventuriero Donald Crowhurst de Il mistero di Donald C. di James Marsh (cui aveva già fornito la preziosa partitura per La teoria del tutto), di fatto è questo lavoro il “manifesto”, l’eredità che ci consegna Jóhann Jóhannsson, compositore che rimpiangeremo a lungo. Un’eredità non a caso affidata discograficamente alla più prestigiosa etichetta di musica classica, anche contemporanea. Ed è un peccato che l’Academy abbia perso una ulteriore occasione per dare un segno di rinnovamento, escludendo (dopo il caso-Silence dei coniugi Kluge) anche questa score dalla corsa agli Oscar 2016, perché colpevole di contenere un brano preesistente di un altro compositore, precisamente il dolente “On the nature of daylight” per quartetto d’archi di Max Richter, scritto nel 2004 per l’album “The blue notebooks” e spesso impiegato al cinema (ad esempio da Scorsese in Shutter Island), qui utilizzato in versione remixata per alcune sequenze che riguardano il personaggio interpretato da Amy Adams: peraltro annotiamo che nel soundtrack si può ascoltare anche il Larghetto della celestiale Serenata in mi maggiore op.22 di Antonín Dvořák…
Ma al di là del cavillo procedurale, facile ipotizzare che i selezionatori siano stati spiazzati e respinti dalle coordinate stilistiche ed estetiche di un lavoro ancora una volta fuori dai canoni che per l'Academy si identificano troppo spesso con una tranquillizzante routine sinfonico-hollywoodiana.