Red Sparrow
 James Newton Howard
James Newton Howard
Red Sparrow (Id., 2018)
Sony Classical 19075842092
20 brani – Durata: 76’48”
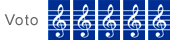
Rappresenta sempre una piacevole sorpresa di questi tempi imbattersi in una partitura filmica della quale auspicare un’immediata e adeguata collocazione concertistica: a maggior ragione se non risulta particolarmente memorabile il film di destinazione, in questo caso un action-sexy-thriller per la star Jennifer Lawrence, nuovamente al servizio del regista Francis Lawrence (solo omonimia, nessuna parentela) dopo il ciclo Hunger Games. La medesima saga, en passant, che ha visto anche il notevole impegno da parte di James Newton Howard, ora qui ritrovato.
Non è solo questione di “orchestra vs. elettronica”. Altre volte il 66enne compositore californiano ha confermato di saper dosare con eleganza ed equilibrio i due elementi senza cedere alle scorciatoie dei software, conservando intatta la propria asciutta intensità di eloquio, e oltretutto recentemente dimostrandosi particolarmente attratto dal lato fantasy, come testimoniano anche i suoi due prossimi, imminenti titoli: Animali fantastici – I crimini di Grindewald, sequel del film del 2016 di David Yates, e Lo schiaccianoci e i quattro regni di Lasse Hallström.
No, non è solo questione di mezzi impiegati ma di concezione, di idee, vorremmo dire di “filosofia” del comporre. Prendiamo la lunghissima “Ouverture” di oltre undici minuti: si tratta per l’appunto di un pezzo da concerto autoconcluso, sviluppato secondo uno schema di forma-sonata senza soluzione di continuità con continui inserimenti solistici e concertanti. Il dipanarsi iniziale degli archi contiene qualcosa di oscuro e misterioso ma carezzevole, sottolineato dal dolce e malinconico intervento tematico dell’oboe, sino ad un episodio più mosso e di sapore inequivocabilmente “slavo”, non immemore del Ciaikovski di “Romeo e Giulietta” e dagli sviluppi contrappuntistici sensazionali; a questo segue una coda di nuovo lenta e solennemente scandita dalle percussioni ma con sonorità più fredde e inquietanti dell’incipit. Si tratta di una tipologia di scrittura decisamente inconsueta per la sua architettura sinfonica tradizionale e nel contempo fantasiosamente innovativa, e per la quale non a caso (così come per gli “End titles”) il compositore ha chiesto il contributo direttoriale di Esa Pekka-Salonen, una delle massime bacchette del nostro tempo ma anche uno dei pochissimi interpreti che si accosta alla musica per film in sede concertistica.
Questo impianto “classico” trova coerenti – mai mai monotone - estensioni nel prosieguo della score, soprattutto nell’ampiezza di respiro e nella sapiente calibratura dei volumi sonori. Così ad esempio, il pedale dissonante di “The steam room” ricorda molto da vicino le atmosfere raggelate di Howard per gli horror di Night Shyamalan, al pari dei magmatici, inafferrabili “Take off your dress” e “Arriving at Sparrow School”; qui in realtà interviene anche l’elettronica, come pura scenografia sonora, al cui interno comunque possono improvvisamente affiorare spettrali arpeggi del violoncello solo (“Training”) o, sempre negli archi, frammenti di un cantabile desertificato e immobile (“There’s a car waiting to take you to Moscow”) di riconoscibile ascendenza herrmanniana.
Il climax, dunque, è più malinconico e meditativo che superficialmente minaccioso, e in questa direzione dall’orchestra può inaspettatamente alzarsi una frase intensa e penetrante dei celli (“Follow the trail wherever it leads you”), mentre in “Blonde suits you” l’oboe ripropone il tema d’inizio (nel quale traspare qualcosa del Silvestri di Le verità nascoste…) per lasciare poi che gli archi tornino a contrarsi in tremoli, flautandi e brevi quanto accorate frasi melodiche che di nuovo rievocano un’atmosfera vagamente “à la Russe”. Si noterà anche che l’azione non è mai accompagnata da impennate dinamiche o terremoti ritmici, ma piuttosto da un ipnotizzante alone di mistero, popolato di segnali sfuggenti (“Ticket to Vienna”, “Switching disks”), di frammenti leitmotivici del tema principale, e di continui ricorsi a quel mesto, preoccupato fraseggiare di archi (“Can I trust you!”). Il tutto sino ai quasi venti minuti che occupano le ultime due tracce, “Didn’t I do well!” e i già citati “End titles”: qui la struttura e l’orchestrazione tornano al pensiero musicale che dominava l’Ouverture, attraverso una scrittura severa e concentrata. Nel primo brano, interviene anche il coro a sostenere un lungo, lento e ansimante ostinato degli archi che sembra risolversi e liberarsi solo nella luminosa coda degli ottoni; anche gli “End titles” paiono prender forma con fatica, tra assoli incerti del flauto e ricapitolazioni tematiche apparentemente casuali; sino alla piena riesposizione del tema conduttore e ad una conclusione che ancora una volta si spegne nel silenzio, da dove tutto era cominciato.
Può senz’altro darsi che una simile impostazione, quasi “accademica”, sia stata adottata da Howard per allinearsi stilisticamente con il ricco parterre di brani classici che popolano la OST, da Bach a Mozart, da Ciaikovski (quello vero…) a Grieg, ma ci pare una spiegazione limitativa. Piuttosto il musicista sembra qui suggestionato dalla nostalgia e dagli insegnamenti di quella che fu la grande scuola cinemusicale hollywoodiana almeno fino a tutti gli anni ’60: la sua però non è una nostalgia sterile (quale nostalgia non lo è?) e piattamente revivalistica, bensì magistero e classe di un vero erede di quella tradizione, capace quindi di innovare nella modernità. L’impresa più difficile, in ogni campo.