Phantom Thread
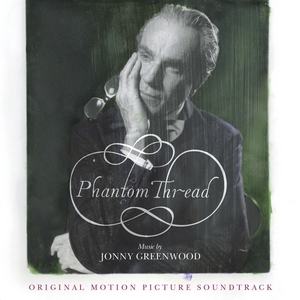 Jonny Greenwood
Jonny Greenwood
Il filo nascosto (Phantom Thread, 2018)
Nonesuch 564777
18 brani – Durata. 55’41”
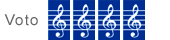
Chi ha seguito con attenzione il sodalizio costituitosi in questi anni fra il chitarrista dei Radiohead e il regista visionario, raffinato e perturbante de Il petroliere, The Master e Vizio di forma sarà senz’altro abituato alla cangiante imprevedibilità e alle variazioni stilistiche delle score di Jonny Greenwood per Paul Thomas Anderson: sono partiture che ambiscono ad incunearsi in profondità, quasi fisicamente, nel complesso universo simbolico del cineasta americano, restituendone angosce, ipnotiche fascinazioni e suggestioni oniriche.
Ma anche questa consuetudine non impedirà di restare sorpresi dinanzi all’ultima tappa di questa collaborazione, incentrata sul profondo sconvolgimento amoroso che colpisce l’esistenza di un rinomato stilista nel vellutato universo della Londra anni ’50 immediatamente precedente i sovvertimenti della “swinging London”. Il soggetto tuttavia non tragga in inganno. Il “romanticismo” di Anderson è obliquo, allusivo, sofisticatamente astratto, enigmatico e intimamente funebre. E da qui discende la sorpresa del lavoro di Greenwood: una partitura rigorosamente strumentale, prevalentemente per archi ma utilizzati spesso in funzione solistica, attraversata da tonalità crepuscolari esasperate e insieme spettrali, quasi cimiteriali, con squarci lirici struggenti e improvvise contrazioni timbriche disseminate di inquiete dissonanze. Il brano d’apertura, “Phantom thread I”, ne è una perfetta esemplificazione con la sua limpida scrittura per violini e il suo andamento ondivago, armonicamente sempre in bilico fra accasciate tonalità minori e vitree modulazioni. Il pacato ma penetrante caos interiore che governa il film e più in generale tutto il cinema di Anderson si esplica ancor meglio nel successivo “The hem”, dove gli archi in veste quartettistica si dividono e si riannodano in una rigida spartizione di piani sonori, implacabilmente governata dalla direzione d’orchestra di Robert Ziegler, accogliendo nel proprio labirinto anche effetti ticchettanti e un pianoforte preparato; ci accorgiamo così che mano a mano che si procede la score veleggia verso una scrittura di dichiarata avanguardia (“Sandalwood I”), dove l’elaborato contrappuntismo da camera, quasi memore delle kammermusik di Schoenberg, si alterna a repentine aperture liriche costruite su temi semplicissimi, come l’incantevole leit-motif discendente di “The tailor of Fitzrovia”, le cui prime cinque note rievocano l’”Amami Alfredo” verdiano.
Altra caratteristica della partitura è la discrezione, il pudore sonoro che la permea: le idee sgorgano dal silenzio, da filiformi enunciazioni del violino solo accompagnato da flebili note basse ribattute del piano (”Alma”), o da dialoghi strumentali scarnificati e illuminati di luce livida (l’assolo del violino in “Phantom thread II”). Anche il ricorso all’organico pieno è utilizzato in chiave impressionistica, come in “Catch hold” dove il piano s’intreccia ad un nebbioso tappeto di archi fissati in cluster avvolgenti. Spuntano eco morriconiane in “Never cursed”, con gli archi acuti che ondulano su dissonanze cicliche mentre altri archi rispondono con accordi secchi e disturbati: e si arriva finalmente allo stupefacente “Phantom thread III”, brano pienamente, sontuosamente sinfonico che chiama a raccolta disperatamente gli archi in una perorazione orchestrale che la scansione ritmica rende simile ad un requiem. Questa vena più scopertamente neoclassica e rigogliosa emerge anche nel fascinoso “House of Woodcock”, dove spiccano il sapiente, morbido fraseggio degli archi e un tematismo dolente ma insieme salottiero, quasi autoironico nel suo fluviale sentimentalismo.
Il “suono” della partitura si fa via via sempre più intossicante, inebriante, mentre gli archi si infiammano senza però mai adagiarsi in una scrittura lineare, compiuta, ma rimanendo sempre sospesi in una “terra di nessuno” armonica: qualcosa che sembra un connubio fra l’orchestra di Mantovani (“Sandalwood II”, assolutamente delirante nel proprio compiaciuto “vintage”), il preludio del primo atto del “Lohengrin” e i quartetti di Shostakovich… E se in “Barbara Rose” si riaffacciano colori secchi, appuntiti, “Endless superstition” ci riporta in atmosfere degne della leggendaria orchestra di Percy Faith e del suo sublime “easy listening”, mentre “Phantom thread IV” è uno straziante, implorante assolo di violino basato sul tema conduttore, e il conclusivo “For the hungry boy” è un’altra esibizione a piena orchestra col pianoforte concertante, un sigillo di nostalgia e colloquiale romanticismo in linea con tutta la seconda parte della score.
Un lavoro, dunque, sin troppo ricco, anzi esplicitamente dilagante e sovraesposto, quello di Greenwood: al quale bisogna poi aggiungere, nel soundtrack, un profluvio di presenze esterne, che vanno da Oscar Peterson a Berlioz, da Duke Ellington a Fauré e Schubert, da Brahms a Billy Strayhorn… Senz’altro il più ambizioso e seducente dei quattro capitoli in cui si articola il tandem tra il musicista e Anderson, e non a caso in corsa per l’Oscar; ma anche il più complesso e ingannevole nella sua confezione apparentemente retrò e “glamour”, dietro la quale si intravedono ansie, turbamenti e squilibri nevrotici raramente espressi con altrettanta intelligenza critica.