La pietra tombale vagelisiana di Hans Zimmer
La pietra tombale vagelisiana di Hans Zimmer

Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch
Blade Runner 2049 (Id. – 2017)
Epic Records
Brani 24 - Durata 1:33:45
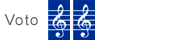
La musica dell’attesissimo film di Denis Villeneuve non ha avuto una gestazione serena, un po’ come accadde per il lontano Blade Runner del 1982. All’epoca Ridley Scott giocò la carta a sorpresa di un compositore “eccentrico”, che veniva dalla Grecia, Vangelis, da poco premiato con l’Oscar per il film Momenti di Gloria. Ma le esitazioni, nello staff del regista, erano tante, perché Evangelos Odyssey Papathanassiou (questo il suo vero nome) era un musicista controcorrente che aveva un curriculum tutto suo: una collaborazione con il gruppo rock degli Aphrodite’s Child negli anni Settanta, alcuni studio-album visionari e svariate OST minori in Francia (soprattutto documentari), già anticipatrici del suo stile sinfoelettronico. Non era un compositore “tradizionale” di musica per film e quella di Scott sapeva di una grande scommessa. Che tuttavia si rivelò profetica e vincente. Perché Vangelis, nel prestare la sua musica al grande schermo, dimostrò una maturità che ancora oggi stupisce (e che di rado si sarebbe ritrovata nei suoi lavori successivi).
Fu una colonna sonora perfetta, cangiante nel suo rimescolio di generi: dall’elettronica minimalista e patetica alla proto-techno aggressiva, dalla neo-classica per coro e arpa al jazz, dalla folk cinese alla vocale “fuori serie” di Demis Roussos. Quell’icona visiva che nel tempo divenne Blade Runner, con le sue atmosfere cupe e spiazzanti, trovò nella colonna sonora la sua linfa vitale e il suo “mood”. Ora, costruire un sequel di quel mondo “perduto” e così idolatrato dai fan, a distanza di così tanto tempo, si è rivelato subito un’impresa per cuori coraggiosi. Il rischio di cadere nel flop e nel ridicolo è altissimo. Va quindi dato atto a Villeneuve di essere riuscito a riannodare con accuratezza i fili dello sci-fi anni ’80 con questo sequel ambientato trent’anni dopo, nel 2049, in una Los Angeles non meno caotica, piovosa, tetra e idiosincratica. Umani falciati dalla miseria, androidi in crisi di identità, ologrammi anelanti un corpo vero… tutto rientra bene nella “mitologia” post-human di questo nuovo scenario, che accarezza così tanti registri da risultare liquidità cinematografica allo stato puro, degno seguito della fumosa pellicola di Ridley Scott (che adesso appare finanche troppo ingenua!) e del romanzo di Philip Dick che sta alla base di tutto (Do Androids Dream of Electric Sheep?). E questo è già un mezzo miracolo. Il film è sobrio nella sua spettacolarità, ordinato nel suo caos interiore, lento nella sua concitazione narrativa. Degne di nota sono la luce che solca in maniera unica ogni singola scena e l’ambientazione paesaggistica che mostra le tracce di un olocausto nucleare o di qualche altro evento estremo. Per scrivere la musica originale di questo imponente affresco il regista Villeneuve, come tutti sapranno, aveva chiamato il suo compositore di fiducia, Jóhann Jóhannsson, il quale si era presentato come un “vangelis-fan” entusiasta, forse troppo. Perché, proprio nell’ultimissima fase di postproduzione, su Jóhannsson è cominciato a calare il mistero ed è stato prima affiancato e poi abbracciato come una mantide religiosa dal re delle colonne sonore, Hans Zimmer in persona, coadiuvato per l’occasione da Benjamin Wallfisch. Villeneuve ha cercato di gettare acqua sul fuoco, Zimmer, diceva, avrebbe scritto solo alcuni temi aggiuntivi. Ma così non è stato, perché alla fine si è saputo che il compositore tedesco è stato incaricato di comporre l’intera OST, mandando in soffitta il lavoro di Jóhannsson (ormai ufficialmente “rejected”). Del quale è pure trapelato qualche audio, ma non abbastanza da farlo apparire come qualcosa di memorabile, sebbene di sapore “vangelis-esque”. Zimmer invece si è mosso in maniera diametralmente opposta. Non ha minimamente cercato di misurarsi con l’eredità di Vangelis, ma è entrato di prepotenza nel film con le sue idee che, da qualche tempo, sono tutt’altro che esaltanti (si veda il recente inascoltabile Dunkirk). L’errore più grave che rende la sua colonna sonora tristemente mediocre, è l’uso di un unico, onnipresente e approssimativo registro espressivo, quello dell’elettronica cyberpunk (che pure trova nella colonna sonora del primo film il suo punto di origine, ma in quel caso era solo una delle molteplici increspature musicali). Mi sto riferendo all’uso ossessivo di pad gravi e a quegli iridescenti synth della Yamaha CS-80, uno degli strumenti cardine della prima OST. Mi va bene, anzi benissimo, la ripresa di atmosfere “pesanti”, monumentali, nichiliste, assordanti, taglienti come lame, ma non si può fare una colonna sonora con quest’unico colore musicale. Perché il film di Villeneuve è, come dicevamo, un arcobaleno di riflessi che andavano sottolineati e amplificati facendo appello a una musica “vera”, non a quella che sembra una “live session” improvvisata alle tastiere elettroniche. Dall’inizio alla fine, da “2049” (che omaggia con poca inventiva gli “Open Titles” del 1982) a “Blade Runner”, brano conclusivo che invece non riprende niente dei famosi “End Titles” d’annata, ci dobbiamo sorbire una serie interminabile di atmosfere ambient che non cambiano di un millimetro. Perdipiù condite da percussioni che fanno saltare dalla sedia o che alludono a ritmi marziali, laddove il film procede su binari completamente diversi e intimisti. Zimmer sembra essere entrato nella cristalleria di Villeneuve con la cautela di un elefante. C’è un’eccezione, ovviamente, ed è l’unico tema musicale che si rintraccia nella score, “Mesa”: interessante, ma è troppo poco. A decretare la pochezza della OST sta l’esecuzione da “pietra tombale” della vangelisiana “Tears in Rain” (qui “Tears in the rain”), presente nel film alla fine, nel momento che si vuole più “emotional” della pellicola. Interpretazione che abbrutisce il più bel momento della vecchia colonna sonora. Non c’è nient’altro da aggiungere.